Fame fisica o fame emotiva? Le differenze
La fame è un meccanismo biologico essenziale per la sopravvivenza dell’essere umano. È un segnale fisiologico che trasmette la necessità di assumere nutrienti essenziali per permettere all’organismo di vivere al meglio.
Tuttavia, non sempre mangiamo perché il corpo ha realmente bisogno di energia. Il cibo spesso diventa risposta a emozioni, rifugio, valvola di sfogo per lo stress.
Comprendere la differenza tra fame fisica e fame emotiva è fondamentale per costruire un rapporto sano con il cibo e adottare uno stile di vita più consapevole.
Che cos’è la fame fisica
La fame fisica o fame fisiologica è un impulso che ci spinge a ricercare il consumo di cibo per assumere nutrienti per produrre energia. Si attiva, infatti, quando le riserve energetiche del nostro organismo iniziano a diminuire.
Questo processo inizia nello stomaco, che quando è vuoto produce un ormone chiamato grelina. Questo ormone viaggia attraverso il flusso sanguigno e arriva all’ipotalamo, la regione del cervello che regola l’appetito. All’azione della grelina si associa anche il calo dei livelli di glucosio nel sangue, intensificando la sensazione di fame.
I segnali della fame fisica
La fame fisica si manifesta attraverso segnali fisici ben definiti, riconoscibili e progressivi.
Il primo segnale è rappresentato dai borborigmi, ovvero i classici “brontolii” dello stomaco, che sono il risultato dalle contrazioni dei muscoli gastrici.
A questo segnale è spesso associata la sensazione di vuoto allo stomaco, che si intensifica gradualmente, un calo di concentrazione, una sensazione di debolezza e irritabilità. Talvolta compare anche un mal di testa lieve, mentre nei casi più estremi sopraggiungono tremori e vertigini.
La fame fisiologica compare sempre gradualmente e si presenta generalmente circa 3-5 ore dopo l’ultimo pasto. Viene soddisfatta da un pasto nutriente, senza “preferenze” di un alimento rispetto ad un altro e, dopo aver mangiato, ci si sente appagati e si smette spontaneamente di mangiare.
Cos’è la fame emotiva
Contrariamente alla fame fisica, la fame emotiva è un impulso non legato alle necessità fisiologiche del corpo. È un bisogno suscitato da uno stato emotivo ed è spesso associata ad una vasta gamma di emozioni, sia negative come ansia, stress, noia, rabbia, tristezza, solitudine, ma anche positive, come gioia e felicità. Per sottolineare il suo legame con lo stato emotivo, viene spesso chiamata anche fame nervosa o fame da stress.
I segnali della fame emotiva
La fame nervosa si manifesta con alcune caratteristiche distintive. In primo luogo, fa la sua comparsa quasi all’improvviso e in modo urgente. È indirizzata verso alimenti specifici, solitamente dolci o cibi grassi. Contrariamente alla fame fisica, può insorgere anche poco tempo dopo un pasto e non si placa con la sazietà fisiologica. Per tale motivo, porta a mangiare in modo veloce ed eccessivo, lasciando un senso di colpa o frustrazione.
La fame emotiva è una risposta compensatoria: si cerca nel cibo una gratificazione, un conforto o una distrazione, anziché ascoltare e gestire l’emozione di fondo.
La fame emotiva dal punto di vista neurobiologico
La fame nervosa attiva circuiti cerebrali diversi da quelli coinvolti nella fame fisica. Lo stress o le emozioni molto intense stimolano la produzione di cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress.
Quando i livelli di cortisolo sono alti, la produzione di grelina e di leptina, gli ormoni che regolano l’appetito e la sazietà, subiscono un’alterazione, generando il desiderio di cibi ad alto contenuto calorico, particolarmente quelli ricchi di zuccheri e grassi.
Fame fisica e fame emotiva: le differenze
Saper distinguere tra fame fisica e fame emotiva è essenziale per coltivare un rapporto sano con il cibo. Le differenze si manifestano in diversi aspetti e saperle riconoscere non è difficile.
Modalità di insorgenza
La fame fisica si sviluppa gradualmente. Al contrario, la fame emotiva spesso si presenta improvvisamente e con un senso di urgenza immediata.
Preferenze alimentari
La fame fisica non è selettiva: qualsiasi cibo nutriente può soddisfarla in modo efficace. La fame da stress, invece, si manifesta con una preferenza verso cibi ricchi di zuccheri, grassi o sale che attivano i centri del piacere nel cervello.
Modalità di consumo
La fame fisica raggiunge naturalmente un punto di sazietà e si smette di mangiare in modo spontaneo. La fame emotiva, al contrario, può portare a episodi di sovralimentazione poiché il cibo non riesce a colmare il vuoto emotivo che l’ha scatenata.
Cosa scatena la fame nervosa
I trigger più comuni includono situazioni di stress lavorativo, problemi relazionali, noia, ansia sociale, o persino abitudini consolidate legate a specifici momenti della giornata.
Sono frequenti anche delle associazioni automatiche tra abitudini e cibo. Il cibo agisce come modello compensatorio o come valvola di sfogo per situazioni emotive che non si è in grado di gestire in modo differente.
Ecco alcuni casi specifici:
- Situazione di stress: il cortisolo aumenta l’appetito e la voglia di zuccheri.
- Sensazione di noia: il cibo rappresenta una stimolazione sensoriale che serve a “riempire” il tempo vuoto.
- Tristezza o solitudine: il cibo agisce da “coccola” consolatoria.
- Momento di ansia: mangiare distrae e dà una temporanea sensazione di sollievo.
- Situazioni felici, gioia: alcune persone associano le emozioni positive al premio alimentare.
Come gestire la fame emotiva
Gestire la fame da stress richiede strategie più articolate che affrontino le cause emotive sottostanti. Sicuramente tecniche di gestione dello stress come la meditazione, l’esercizio fisico e pratiche di rilassamento possono ridurre gli episodi di fame nervosa.
Vi sono anche altre piccole strategie che possono essere un valido supporto:
- Fare una pausa prima di mangiare: aspetta 10 minuti prima di cedere alla voglia di cibo. Spesso il senso di urgenza svanisce da solo.
- Annotare cosa provi: tieni un diario delle emozioni legate al cibo per individuare i tuoi trigger emotivi ed evitarne la ripetizione.
- Creare alternative consolatorie: sostituisci l’automatismo del cibo con altre attività che ti piacciono, come una passeggiata, un bagno caldo, una telefonata a un amico, un libro.
- Mangiare con consapevolezza: non mangiare davanti alla TV o al computer. Mastica lentamente e soffermati sul sapore di ogni boccone.
- Non colpevolizzarsi: se cedi alla fame emotiva, evita i sensi di colpa. Comprendi cosa è accaduto e impara dall’esperienza.
L’importanza dell’equilibrio
Comprendere la differenza tra fame fisica e fame emotiva non significa eliminare ogni aspetto di piacere legato al cibo e nutrirsi solo per soddisfare un bisogno fisiologico. Il cibo può essere anche un’occasione di socialità, una celebrazione, ma a fare la differenza è l’equilibrio!
Se si tratta di un’occasione e non di un’abitudine, abbiamo la possibilità di vivere in modo sano il nostro rapporto con il cibo, sviluppando consapevolezza ed evitando che il cibo diventi una modalità di gestione delle emozioni.
Se la fame emotiva dovesse diventare frequente e incontrollabile e dovesse causare disagio psicologico o disturbi alimentari, è fondamentale rivolgersi al proprio medico di fiducia, che saprà consigliare al meglio su come agire.

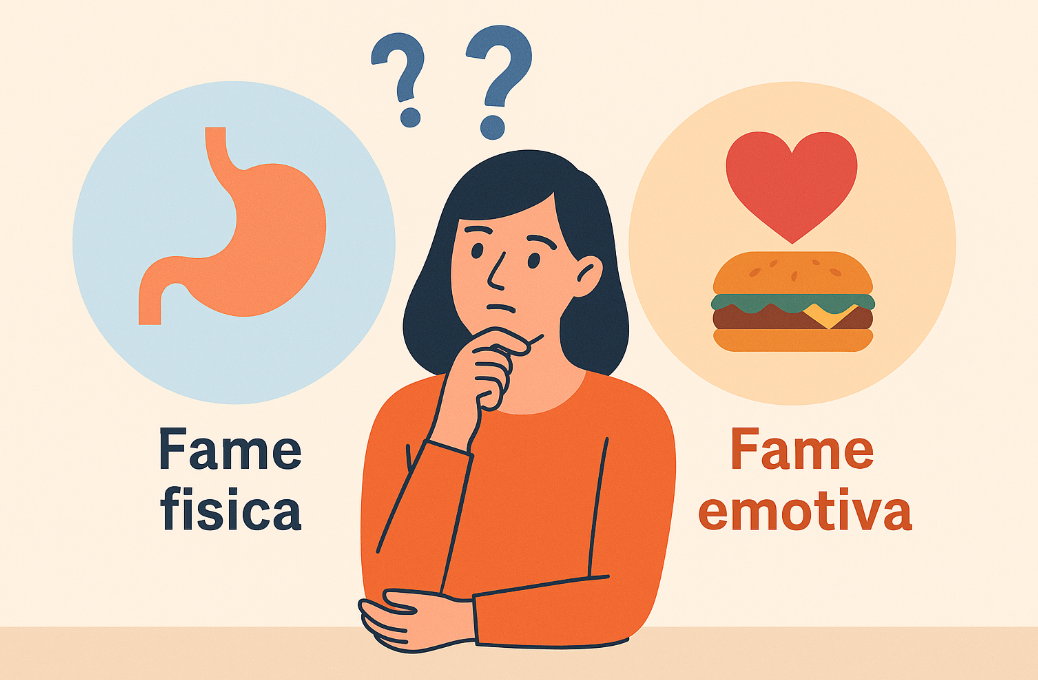
2 thoughts on “Fame fisica o fame emotiva? Le differenze”
Comments are closed.